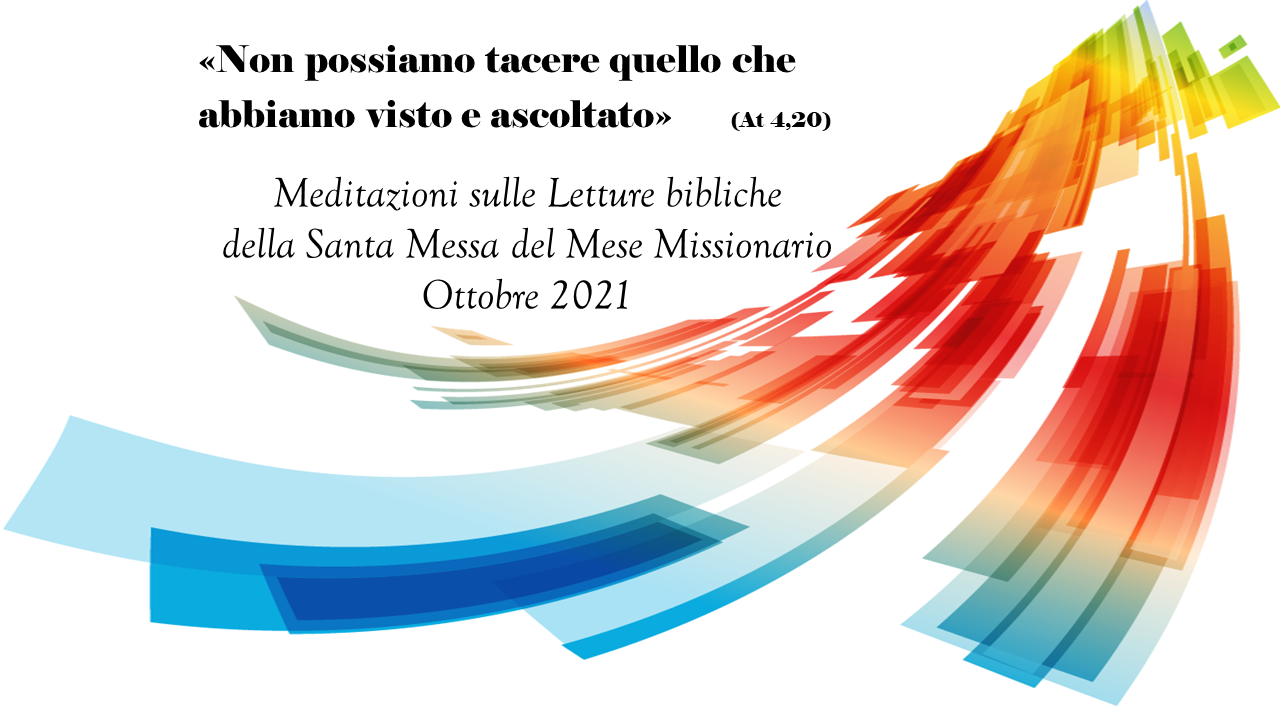
18 ottobre 2021 - Festa di San Luca, evangelista
2 Tm 4, 10-17b
Sal 144
Lc 10, 1-9
Scriba della mansuetudine di Cristo, come lo definisce Dante, Luca, discepolo della seconda generazione cristiana, era un uomo colto, medico, probabilmente proveniente da Antiochia di Siria. Non apparteneva al gruppo degli apostoli e nemmeno ai 72 discepoli e non aveva conosciuto Gesù.
Scrive San Paolo VI nella sua Esortazione Apostolica Evangelii Nuntiandi:
La testimonianza che il Signore dà di se stesso e che San Luca ha raccolto nel suo Vangelo - «Devo annunziare la Buona Novella del Regno di Dio» - ha senza dubbio una grande portata, perché definisce con una parola la missione di Gesù: «Per questo sono stato mandato». Queste parole acquistano tutta la loro significazione, se si accostano ai versetti precedenti, dove il Cristo aveva applicato a se stesso l'espressione del profeta Isaia: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto annuncio». Proclamare di città in città, soprattutto ai più poveri, spesso più disposti, il gioioso annuncio del compimento delle promesse e dell'Alleanza proposta da Dio: tale è la missione per la quale Gesù si dichiara inviato dal Padre. E tutti gli aspetti del suo Ministero - la stessa Incarnazione, i miracoli, l'insegnamento, la chiamata dei discepoli, l'invio dei Dodici, la Croce e la risurrezione, la permanenza della sua presenza in mezzo ai suoi - sono componenti della sua attività evangelizzatrice (EN 6, 8 dicembre 1975).
Il Vangelo di San Luca testimonia la grande misericordia di Dio e la predilezione di Gesù per i poveri. È il Vangelo della preghiera e della gioia. I personaggi femminili sono numerosi nel suo Vangelo e sempre trattati con delicatezza. Si può pensare che le notizie sull’annunciazione dell’angelo a Maria, sulla nascita e sull’infanzia del Messia gli siano state comunicate direttamente da Maria stessa o almeno da testimoni credibili vissuti con Maria. La leggenda narra che San Luca era anche abile pittore: tante icone della Madonna sono state attribuite alla sua opera.
La modestia di San Luca, a cui, oltre il Vangelo, è attribuito il libro degli Atti degli Apostoli che ne è la prosecuzione, è tale che veniamo a conoscere il suo nome solo da San Paolo, che egli ha accompagnato in alcuni viaggi e che lo cita per tre volte.
Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalònica; Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tìchico a Èfeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Tròade in casa di Carpo, e i libri, soprattutto le pergamene (2Tm 4, 10-13).
Come Paolo, S. Luca è stato un grande propagatore della ‘buona notizia’ di Cristo e, con lui, ha portato a compimento l’annuncio del Vangelo perché tutte le genti lo ascoltassero.
Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni: il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione.
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero (2Tm 4, 14-17).
Il salmo responsoriale invita il cosmo e i fedeli a lodare e a benedire il Signore. Tutte le cose e tutti gli uomini devono parlare della gloria e della potenza di Dio per farle conoscere a tutti. A tutti devono comunicare che Dio regna per sempre con giustizia e bontà ed è vicino a chi lo invoca:
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
Il Vangelo ci descrive l’invio in missione dei discepoli:
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: "Pace a questa casa!". Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: "È vicino a voi il regno di Dio"».
Per commentare questo Vangelo abbiamo scelto l’omelia di un altro grande evangelizzatore: San Gregorio Magno, Padre e Dottore della Chiesa. Dapprima Prefetto di Roma, divenne monaco benedettino e poi fu eletto Sommo Pontefice in tempi estremamente difficili per la città di Roma, per la Chiesa e per l’Europa; fu lui che inviò quaranta monaci benedettini ad evangelizzare la Britannia, ottenendo la conversione di quei popoli:
Il Signore e Salvatore nostro, o fratelli carissimi, ora ci ammonisce coi sermoni, ora con le opere. Le sue stesse azioni sono precetti, perché, mentre opera tacitamente qualche cosa, ci segnala ciò che dobbiamo fare.
Eccolo inviare i discepoli, a due a due, a predicare, perché due sono i precetti della carità, cioè l'amore a Dio e al prossimo. La carità non si può avere meno che fra due. Perché vi possa essere carità, l'amore deve tendere verso un altro: non si dice propriamente che uno abbia carità verso se stesso. Il Signore manda i discepoli a predicare, a due a due, per accennarci tacitamente che chi non ha carità verso un altro, non deve in nessun modo addossarsi l'ufficio della predicazione.
Opportunamente si dice che “li mandò ...innanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stava per andare (Lc 10,1). Il Signore infatti segue i suoi predicatori, perché la predicazione lo previene, e viene nell'abitazione della nostra mente quando lo hanno preceduto le parole dell'esortazione, per le quali si riceve la verità. E' per questo che lo stesso Isaia dice ai predicatori: “Preparate la via del Signore, raddrizzate... i sentieri del nostro Dio” (Is 40,3). È per questo che ad essi il Salmista dice: “Preparate la strada a colui che ascende verso il tramonto” (S 67,5 volg.).
Verso il tramonto infatti il Signore ascese, perché la morte toccatagli nella passione gli diede modo di manifestare maggiormente la sua gloria con la risurrezione. Verso il tramonto ascese, perché risorgendo calpestò la morte che aveva sopportato. A lui, dunque, che ascende verso il tramonto, facciamo noi la strada quando predichiamo alle vostre menti la sua gloria, affinché, giungendo poi egli, le illumini colla presenza del suo amore.
Sentiamo cosa dice il Signore nell’inviare i predicatori: «La messe è molta, ma gli operai sono pochi! Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe!» (Mt 9, 37-38). Per una grande messe gli operai sono pochi; non possiamo parlare di questa scarsità senza profonda tristezza, poiché vi sono persone che ascolterebbero la buona parola, ma mancano i predicatori. Ecco, il mondo è pieno di sacerdoti, e tuttavia si trova di rado chi lavora nella messe del Signore; ci siamo assunti l’ufficio sacerdotale, ma non compiamo le opere che l’ufficio comporta.
Riflettete attentamente, fratelli carissimi, su quello che è scritto: «Pregate il padrone della messe, perché mandi operai per la sua messe». Pregate voi per noi, affinché siamo in grado di operare per voi come si conviene, perché la lingua non resti inceppata nell’esortare, e il nostro silenzio non condanni presso il giusto giudice noi, che abbiamo assunto l’ufficio di predicatori.
Spesso infatti la lingua dei predicatori perde la sua scioltezza a causa delle loro colpe; spesso invece viene tolta la possibilità della predicazione a coloro che sono a capo per colpa dei fedeli. La lingua dei predicatori viene impedita dalla loro nequizia, secondo quanto dice il salmista: «All’empio Dio dice: Perché vai ripetendo i miei decreti?» (S 49, 16).
Altre volte la voce dei predicatori è ostacolata colpevolmente dai fedeli, come il Signore dice a Ezechiele: «Ti farò aderire la lingua al palato e resterai muto. Così non sarai più per loro uno che li rimprovera, perché sono una genìa di ribelli» (Ez 3, 26). Come a dire: Ti viene tolta la parola della predicazione, perché il popolo non è degno di ascoltare l’esortazione della verità, quel popolo che nel suo agire mi è ribelle. Non è sempre facile però sapere per colpa di chi al predicatore venga tolta la parola. Ma si sa con tutta certezza che il silenzio del pastore nuoce talvolta a lui stesso, e sempre ai fedeli a lui soggetti. Vi sono altre cose, fratelli carissimi, che mi rattristano profondamente sul modo di vivere dei pastori. E perché non sembri offensivo per qualcuno quello che sto per dire, accuso nel medesimo tempo anche me, quantunque mi trovi a questo posto non certo per mia libera scelta, ma piuttosto costretto dai tempi calamitosi in cui viviamo.
Ci siamo ingolfati in affari terreni, e altro è ciò che abbiamo assunto con l’ufficio sacerdotale, altro ciò che mostriamo con i fatti. Noi abbandoniamo il ministero della predicazione e siamo chiamati vescovi, ma forse piuttosto a nostra condanna, dato che possediamo il titolo onorifico e non le qualità.
Coloro che ci sono stati affidati abbandonano Dio e noi stiamo zitti. Giacciono nei loro peccati e noi non tendiamo loro la mano per correggerli.
Ma come sarà possibile che noi emendiamo la vita degli altri, se trascuriamo la nostra?
Tutti rivolti alle faccende terrene, diventiamo tanto più insensibili interiormente, quanto più sembriamo attenti agli affari esteriori.
Ben per questo la santa Chiesa dice delle sue membra malate: «Mi hanno messo a guardiana delle vigne; la mia vigna, la mia, non l’ho custodita» (Ct 1, 6).
Posti a custodi delle vigne, non custodiamo affatto la vigna, perché, implicati in azioni estranee, trascuriamo il ministero che dovremmo compiere.
(Omelia XVII, tenuta ai vescovi in Laterano)

