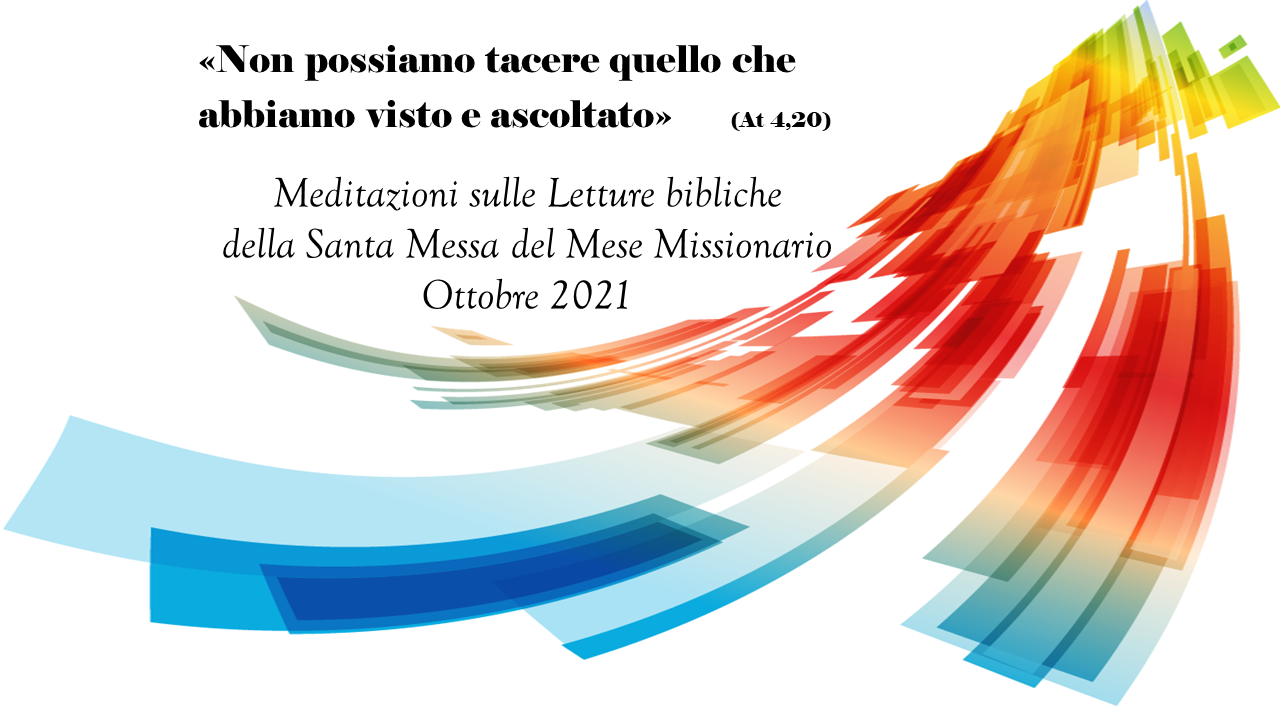
26 ottobre 2021 - Martedì, 30a Settimana del Tempo Ordinario
Rm 8, 18-25
Sal 125
Lc 13, 18-21
Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio.
Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati.
Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza.
Nel brano odierno della lettera ai Romani San Paolo ci offre un quadro preciso del mondo redento da Cristo e ci presenta con estremo realismo, ma anche con speranza, la condizione odierna dell’uomo e di tutta la creazione.
Benché salvato, benché reso figlio di Dio, l’uomo vive nel dolore, nell’attesa di un compimento che non è ancora stato raggiunto. Abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, ma solo come caparra; possediamo le primizie dello Spirito, non la pienezza, e il nostro corpo non è ancora stato totalmente redento. Anche tutta la creazione partecipa a questa sofferenza e a questa attesa, per colpa dell’uomo che con il peccato l’ha fatta entrare nella schiavitù della corruzione.
Ma, dice San Paolo, l’uomo e la creazione, in questo stato di caducità e di dolore, stanno vivendo non una morte, ma una gestazione per il parto. Essa naturalmente comporta ansia e sofferenza, ma va verso la vita vera: l’uomo e la creazione sono protesi alla gloria che ancora non vedono, ma che aspettano di vedere. Le condizioni per vedere quello che ancora non si vede, consistono nell’aspettarlo con speranza e con perseveranza.
E il salmo responsoriale offre subito un esempio di rinascita, anche se non si tratta ancora di felicità completa, perché siamo ancora sulla terra. I deportati a Babilonia, anche se in piccolo numero e in mezzo a gravi difficoltà, sono tornati liberi nella loro terra! “Eravamo pieni di gioia”, dice il salmista. Il Signore sa che le sue creature non possono vivere senza la gioia, anche se fragile e provvisoria e, nella sua tenerezza, tempera le prove dell’esilio sofferto. Ci mette alla prova, saggia la nostra fedeltà, vuole che gli testimoniamo speranza e perseveranza, ma non ci fa mancare né grandi gioie dopo periodi di acute sofferenze, né piccole gioie quotidiane che ci permettono di avanzare felici anche in mezzo alle tribolazioni:
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni.
Il vangelo odierno è singolarmente in sintonia con l’epistola e il salmo: ci regala molta fiducia e speranza.
In quel tempo, diceva Gesù: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape, che un uomo prese e gettò nel suo giardino; crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami». E disse ancora: «A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
L’immagine del regno di Dio offertaci da S. Luca è semplice e familiare, tale da non spaventare nessuno. Il regno di Dio è simile a un granello di senape… È simile al lievito… Il granello di senape e il lievito sono realtà piccole, alla nostra portata, eppure hanno in sé una forza straordinaria, che non viene certamente da noi. Noi abbiamo la capacità e la responsabilità di utilizzare bene questi elementi, di farli servire allo scopo per cui Dio li ha creati: seminare il granello nel nostro giardino o mescolare il lievito nella nostra farina per la crescita del regno di Dio. Non siamo noi, ma è la grazia di Dio che fa crescere, senza che noi sappiamo come. “La misteriosa fecondità della missione non consiste nelle nostre intenzioni, nei nostri metodi, nei nostri slanci e nelle nostre iniziative, ma riposa proprio in questa vertigine: la vertigine che si avverte davanti alle parole di Gesù, quando dice ‘senza di me non potete far nulla”. (Papa Francesco, Senza di Lui non possiamo far nulla. Essere missionari oggi, LEV-San Paolo, Roma 2019, p. 36)
In noi il regno di Dio cresce, a patto però che prendiamo coscienza della nostra povertà e dell’incapacità di salvarci da soli. Cristo, con la sua vita, morte, risurrezione ci ha già salvati: noi dobbiamo solo crederlo, sperarlo e offrire la nostra piccola collaborazione a questa salvezza, che non vediamo ancora nella sua totalità. Adoriamo l’iniziativa e il dono che riceviamo e operiamo con fiducia tutto quello che possiamo compiere da parte nostra, anche se è poco. E cerchiamo di essere grati per la misericordia di cui siamo oggetto da parte di Dio.
La nostra collaborazione alla grazia è sempre opera missionaria, anzi è l’unica opera veramente missionaria, perché la testimonianza della vita è la forma più convincente di apostolato. E questo avviene specialmente se la testimonianza è legata ad una grande sofferenza, vissuta con amore, e perfino con gioia e con il sorriso sulle labbra.
È quello che è avvenuto ad una santa libanese, Rafqa Choboq Ar-Rayes, morta nel 1914 e canonizzata dal Papa Giovanni Paolo II il 10 giugno 2001:
Canonizzando la beata Rafqa Choboq Ar-Rayes, la Chiesa illumina in modo particolare il mistero dell'amore donato e accolto per la gloria di Dio e la salvezza del mondo. Questa monaca dell'Ordine libanese maronita desiderava amare e dare la propria vita per i suoi fratelli. Nelle sofferenze che non hanno cessato di tormentarla negli ultimi ventinove anni della sua esistenza, santa Rafqa ha sempre manifestato un amore generoso e appassionato per la salvezza dei fratelli, traendo dalla sua unione con Cristo, morto sulla croce, la forza di accettare volontariamente e di amare la sofferenza, autentica via di santità.
Possa santa Rafqa vegliare su quanti conoscono la sofferenza, in particolare sui popoli del Medio Oriente che devono affrontare la spirale distruttrice e sterile della violenza! Per sua intercessione, chiediamo al Signore di aprire i cuori alla ricerca paziente di nuove vie per la pace, affrettando i giorni della riconciliazione e della concordia!
(Cappella Papale per la Canonizzazione di 5 Beati, Omelia di Giovanni Paolo II, Santissima Trinità, 10 giugno 2001)
Dato il lungo periodo di cecità e di totale paralisi, non ci sono rimasti scritti dell’umile monaca, compatriota e contemporanea del famoso taumaturgo San Charbel Makhluf.
Era entrata dapprima in una Congregazione di vita apostolica e mandata come insegnante nei villaggi di montagna; solo in seguito era divenuta monaca contemplativa nello stesso Ordine di San Charbel.
Santa Rafqa aveva vissuto nell’infanzia e nell’adolescenza la guerra civile e le divisioni che avevano impoverito le famiglie libanesi dal 1840 al 1845, ma aveva sofferto soprattutto per lo sterminio dei maroniti del 1860, durante il quale i bambini venivano strappati dalle braccia delle loro madri e uccisi. La Santa poté salvare un bambino, nascondendolo nel suo abito, difendendolo così dalla crudeltà e dalle barbarie di coloro che lo inseguivano. Rimase sempre tanto turbata da questi massacri, che si commuoveva ogni volta che qualcuno gliene parlava.
Passata nel 1871 dalla Congregazione delle Mariamite di Bikfaya, che era stata dissolta, all’Ordine libanese delle Monache Maronite, desiderò unirsi maggiormente alle sofferenze di Cristo, chiedendogli di partecipare alla sua passione. E così avvenne. Perse un occhio durante un’operazione e poi divenne definitivamente cieca. Tutto il suo corpo si paralizzò, tranne le mani, che le consentirono di lavorare a maglia durante tutta la sua vita. Visse fino all’età di 82 anni con il sorriso sulle labbra, in perfetta letizia.
Dopo la sua morte, sulla sua tomba, si verificò lo stesso fenomeno che si era visto su quella di San Charbel: una luce splendente brillava e poi spariva. Alcune persone dei villaggi vicini al monastero di San Giuseppe di Jrapta videro quel prodigio e ne dettero testimonianza.
Il messaggio di Santa Rafqa, per ogni cristiano che si trova nel dolore, è un incoraggiamento alla pazienza e all’accettazione gioiosa della sofferenza per amore di Cristo e del prossimo, secondo il detto che colui che cerca Gesù Cristo senza la croce, troverà la croce senza Gesù Cristo e gli riuscirà gravoso e persino impossibile di portarla. Rafqa ci insegna che, con Cristo ed attraverso di Lui, la Croce e le molte sofferenze della vita diventano preghiera e letizia e sono la forma più efficace di evangelizzazione.

