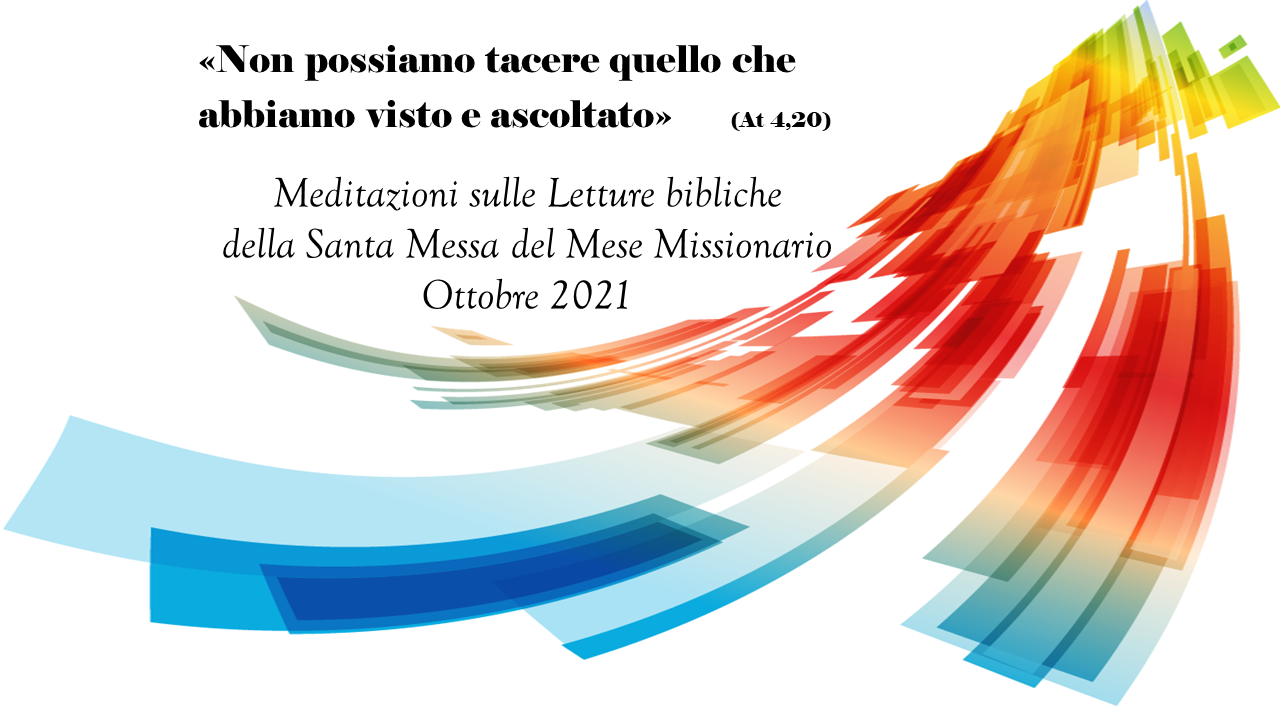
4 ottobre 2021 - Memoria di San Francesco d’Assisi
Lunedì, 27a Settimana del Tempo Ordinario
Gio 1, 1-2, 1.11
Gio 2, 3-5.8
Lc 10, 25-37
Inizia oggi la lettura del profeta Giona, che proseguirà nei due giorni successivi, facendoci conoscere il piccolo libro per intero. Si tratta di uno scritto didattico, pieno di ironia nei confronti del profeta e ricco di spunti universalistici, che segnano una vetta negli scritti dell’Antico Testamento. Il Vangelo narra invece la bellissima parabola del buon samaritano.
I due testi, pur essendo stati scritti in epoche tanto diverse, presentano alcuni tratti comuni: criticano la visione teologica ristretta della classe religiosa dominante, affermano con chiarezza in che cosa consiste la vera religione e testimoniano l’universalità della salvezza.
Il Signore Gesù inviò i suoi apostoli a tutte le persone, a tutti i popoli e a tutti i luoghi della terra. Negli apostoli la chiesa ricevette una missione universale, che non ha confini e riguarda la salvezza nella sua integrità, secondo quella pienezza di vita che Cristo è venuto a portare (Gv 10,10) essa fu «inviata a rivelare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutti i popoli della terra». Tale missione è unica, avendo la stessa origine e finalità; ma all'interno di essa si danno compiti e attività diverse. Anzitutto, c'è l'attività missionaria che chiamiamo missione ad gentes in riferimento al Decreto conciliare: si tratta di un'attività primaria della chiesa, essenziale e mai conclusa. Infatti, la chiesa «non può sottrarsi alla missione permanente di portare il Vangelo a quanti sono milioni e milioni di uomini e donne ancora non conoscono Cristo, redentore dell'uomo. È questo il compito più specificamente missionario che Gesù ha affidato e quotidianamente affida alla sua chiesa» (Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio n. 31, 7 dicembre 1990).
Ambedue i testi biblici di Giona e dell’evangelista Luca, pervasi dalla universalità della misericordia divina, sono pieni di movimento e di missione, di fughe, di viaggi, di ritorni, di contrasti fra chi fa la volontà di Dio e chi preferisce la propria.
In quei giorni, fu rivolta a Giona, figlio di Amittài, questa parola del Signore: «Alzati, va’ a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me». Giona invece si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore (Gio 1, 1-3).
Giona si oppone alla volontà salvifica di Dio: sa bene che il Signore guarderà favorevolmente i gesti di umiliazione degli abitanti di Ninive, che pure non appartengono al popolo eletto e sono peccatori. Dio finirà per perdonarli al primo segno del loro pentimento. Giona non è per niente d’accordo con questa misericordia, che egli giudica come debolezza. Quindi cerca di scappare a Tarsis, agli estremi confini del mondo allora conosciuto, illudendosi in tal modo di sfuggire alla volontà del Signore. Si susseguono poi altri avvenimenti in modo incalzante: lo scatenarsi della tempesta, lo spavento dei marinai, il sorteggio per sapere chi sia stato il responsabile della loro disgrazia, la confessione di Giona. I marinai, in confronto a Giona, appaiono profondamente religiosi e decisi a seguire non la loro volontà, ma quella del Signore:
Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano, perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa’ che noi non periamo a causa della vita di quest’uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere». Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e gli fecero promesse.
Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona; Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti. E il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia (Gio 1,13-2, 1.11).
Né il mare, né il grosso pesce sopportano la grettezza del profeta disobbediente: per ordine di Dio, dopo tre giorni, lo rovesciano sulla spiaggia. Sappiamo bene che il Signore Gesù non ha paura di appropriarsi di questo episodio romanzesco per farne il segno della sua discesa agli inferi e della sua resurrezione (Cf. Mt 12,39-40).
L’autore sacro, facendo sopravvivere Giona e preparandolo per altre azioni dense di grandi insegnamenti, può intercalare nel racconto uno stupendo cantico poetico di azione di grazie.
Il salmo responsoriale dell’odierna celebrazione della Parola ci offre alcuni versetti di questo cantico del profeta che, angosciato e pentito, invoca Dio dal profondo dell’abisso marino ed è ascoltato dal Signore:
Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto; dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi hai gettato nell’abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno circondato; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Io dicevo: «Sono scacciato lontano dai tuoi occhi; eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio». Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio.
Anche nel Vangelo sono presenti scene che esprimono molto movimento, simbolo del cammino della nostra vita terrena: un uomo scende da Gerusalemme a Gerico; i briganti che lo assaltano e se ne vanno lasciandolo mezzo morto; il sacerdote e il levita anch’essi in viaggio, passano oltre; un Samaritano, che scendeva per quella medesima strada, soccorre il ferito, lo porta in una locanda e riparte, promettendo di ritornare. In questo viaggio – lo abbiamo già visto a proposito di Giona – ci sono episodi e incontri che possono farci comprendere il vero senso della vita e del nostro legame con Dio e con i fratelli.
Nel brano evangelico, per ben tre volte, appare anche una critica aperta alle guide religiose del popolo: all’inizio è un dottore della legge che, “per mettere alla prova Gesù”, lo interroga su che cosa deve fare per avere la vita eterna e poi, “volendo giustificarsi”, gli chiede: “E chi è il mio prossimo?” Nel seguito della parabola, raccontata da Gesù, sono un sacerdote e un levita che, probabilmente per non contaminarsi con il sangue di un povero ferito, mancano al loro preciso dovere di soccorrerlo e quindi trascurano il vero nucleo della Legge per ottemperare a regole di purità meno importanti e caduche. Al centro del racconto c’è la figura del Samaritano, anch’egli in viaggio per i suoi affari che, avendone compassione, soccorre il malcapitato caduto nelle mani dei briganti, ne lava le ferite, lo carica sulla sua propria cavalcatura e lo conduce ad una locanda, pagando l’albergatore, affidandolo alle sue cure e promettendogli altro denaro al suo ritorno per compensarlo delle sue attenzioni verso il ferito. È un Samaritano, quindi uno straniero, un uomo che dai Giudei era considerato un eretico.
La domanda capziosa del dottore della Legge: “E chi è il mio prossimo?”, indica che nella sua mente e nel suo cuore vi era una netta distinzione fra vicini e lontani, correligionari o no, come del resto nella comune mentalità religiosa dell’epoca. Gesù risponde rovesciando la questione: sei tu che devi farti prossimo di chiunque è nel bisogno, senza considerare chi ti è vicino per razza, religione o cultura. Se tu ti fai prossimo a lui, indubbiamente egli diverrà “prossimo” per te.
Dopo questo rovesciamento così chiaro e preciso, Gesù invia il dottore della Legge, come Dio aveva fatto con Giona, in missione: “Va’ e anche tu fa’ così”.
Molti Padri della Chiesa hanno visto nella figura del Samaritano, Cristo che cura le ferite dell’umanità, provocate dal peccato, e si fa prossimo della nostra miseria e infelicità. La locanda dove Egli trasporta l’umanità ferita è la Chiesa, che continua la sua opera di salvezza mediante la predicazione e i sacramenti. Ogni cristiano è chiamato a prendere parte all’azione salvifica della Chiesa, collaborando alla salvezza di chi, vicino o lontano, ha bisogno di soccorso spirituale e materiale, di aiuto fraterno, di amore e di vicinanza.
Oggi facciamo memoria di San Francesco d’Assisi, il fratello universale, il santo forse più simile a Cristo, che con la sua testimonianza di dolcezza, amore e povertà ha operato una trasformazione profonda nella società e nella Chiesa del suo tempo e di ogni tempo.
Le fonti francescane ci offrono molte frasi di Francesco che possono commentare i testi che abbiamo meditato e offrirci degli spunti sul modo in cui offrire la ricchezza del Vangelo ai nostri fratelli vicini e lontani, mediante le parole e le opere:
Quanto sono beati e benedetti quelli che amano il Signore e fanno così come dice il Signore stesso nel Vangelo: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l’anima, e il prossimo tuo come te stesso». Amiamo dunque Dio e adoriamolo con cuore puro e mente pura […] (FF 186-187).
Facciamo, inoltre, frutti degni di penitenza. E amiamo i prossimi come noi stessi. E se uno non vuole amarli come se stesso, almeno non arrechi loro del male, ma faccia del bene (FF 190).
I frati poi che vanno tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti a ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. L’altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché essi credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani […] (FF 43).
Nel n. 34 dell’enciclica Lumen fidei, la prima del pontificato di Papa Francesco, ma pensata e scritta in prima stesura da Papa Benedetto XVI per completare le encicliche che aveva già scritte sulla speranza e sulla carità (a questa prima stesura Papa Francesco ha aggiunto “ulteriori contributi”), leggiamo:
La luce dell’amore, propria della fede, può illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità. La verità oggi è ridotta spesso ad autenticità soggettiva del singolo, valida solo per la vita individuale. Una verità comune ci fa paura, perché la identifichiamo con l’imposizione intransigente dei totalitarismi. Se però la verità è la verità dell’amore, se è la verità che si schiude nell’incontro personale con l’Altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura nel singolo e può fare parte del bene comune.
Essendo la verità di un amore, non è verità che s’imponga con la violenza, non è verità che schiaccia il singolo. Nascendo dall’amore può arrivare al cuore, al centro personale di ogni uomo. Risulta chiaro così che la fede non è intransigente, ma cresce nella convivenza che rispetta l’altro.
Il credente non è arrogante; al contrario, la verità lo fa umile, sapendo che, più che possederla noi, è essa che ci abbraccia e ci possiede. Lungi dall’irrigidirci, la sicurezza della fede ci mette in cammino, e rende possibile la testimonianza e il dialogo con tutti.
La testimonianza della vita e, quando vedranno che piace a Dio, l’annunzio della sua parola, nella dolcezza e nel rispetto, sono quindi gli elementi fondamentali della missione.

